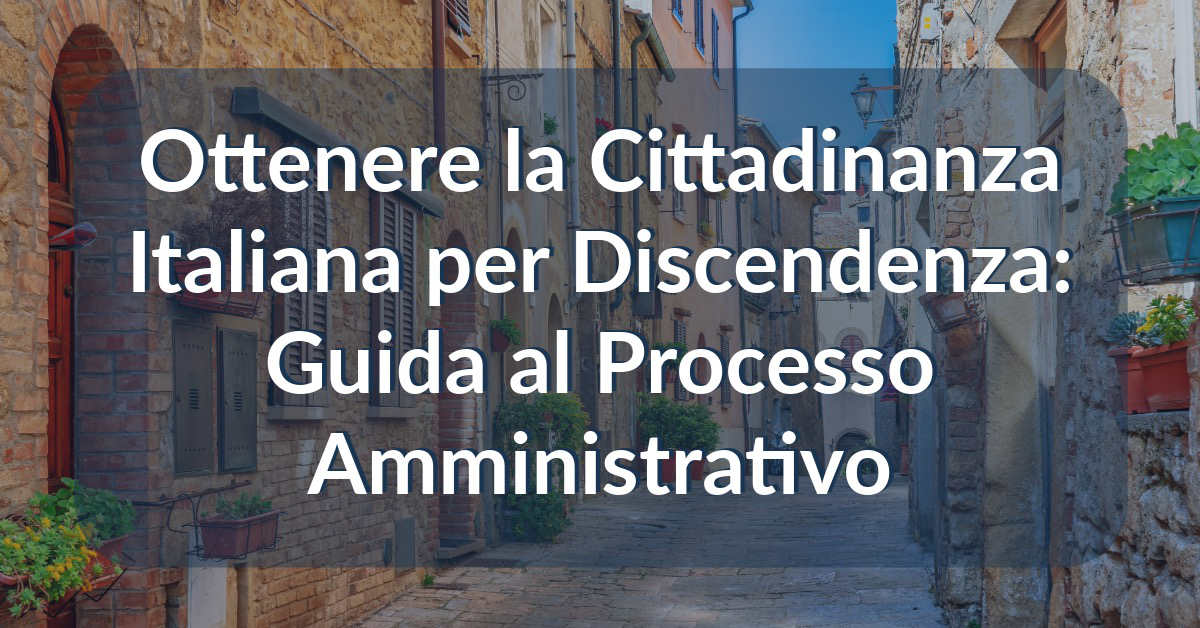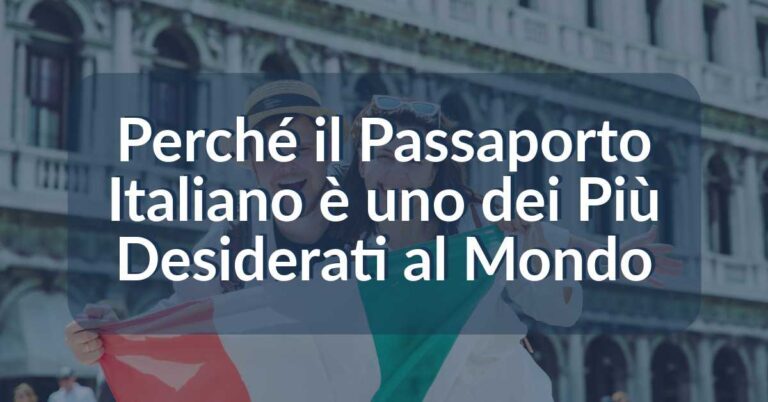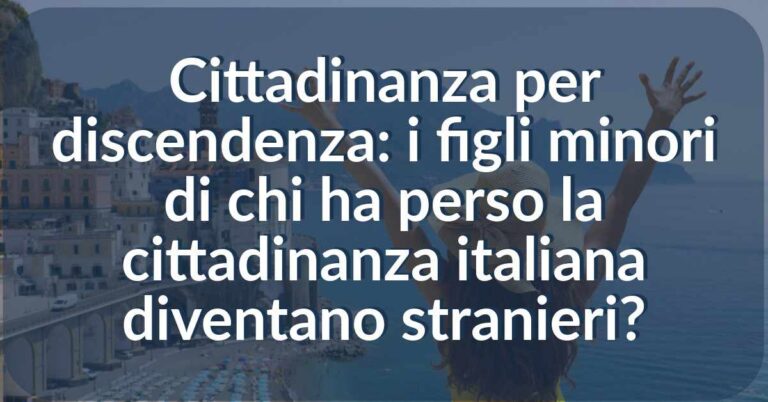Ottenere la Cittadinanza Italiana per Discendenza: Guida al Processo Amministrativo
Sei interessato ad ottenere la cittadinanza italiana per discendenza e non sai come procedere? Sei nel posto giusto. In questa guida ti spiegheremo come fare. Prima di cominciare, ti consigliamo la lettura di questo articolo introduttivo sulla cittadinanza inerente ai vari modi di acquisto della stessa in Italia.
Che cos’è la cittadinanza italiana per discendenza per via amministrativa e qual è il quadro normativo che la regola?
Riguardo l’acquisto della cittadinanza, si fa riferimento alla legge numero 91 del 1992. Il principio cardine è quello dello ius sanguinis, come stabilito dall’articolo 1, secondo il quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini italiani. Questa modalità di acquisizione è denominata “cittadinanza jure sanguinis”.
Secondo questo principio, il discendente di un emigrato italiano (sempre che non sia in possesso di una cittadinanza straniera) può richiedere la cittadinanza italiana jure sanguinis. A livello pratico, quindi, vi è la possibilità per i discendenti (di seconda, terza, quarta generazione o oltre) di emigrati italiani di essere dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Storicamente, questa fattispecie ha riguardato soprattutto i discendenti di avi italiani nati nei Paesi di antica emigrazione (come Brasile, Argentina, Canada, Australia, ecc).
Ricordiamo che la Corte Costituzionale italiana (sentenza numero 30 del 9 febbraio 1983), ha dichiarato incostituzionale l’articolo 1 della legge numero 555 del 1912 (legge precedente che regolava la cittadinanza), nella parte in cui non prevedeva che diventasse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, per violazione degli articoli 3 e 29 della Costituzione. (leggi questo articolo sulla storia della cittadinanza se vuoi approfondire).
Dopo questo intervento, è stato possibile equiparare uomo e donna in materia di cittadinanza. Conseguenziale è stata la promulgazione della legge 123 del 1983 (articolo 5 “E’ cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e, poi, della legge numero 91 del 1992, attualmente in vigore (articolo 1, lettera a- “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”).
Per cui, potevano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, a condizione di essere nati dopo il 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione) e di avere, la madre, il possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Questo era l’orientamento seguito dal Ministero dell’Interno italiano; dopodiché, è stata la Corte di Cassazione italiana (con sentenza a Sezioni Unite del 2009) a riconoscere pacificamente il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale (quindi tramite Tribunale- leggi qui per saperne di più) anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
In questa guida, però, analizzeremo nel dettaglio la procedura amministrativa.
Segnaliamo anche la lettura della Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 del 1991 che descrive il procedimento per ottenere la cittadinanza iure sanguinis.
Come si presenta la domanda per ottenere la cittadinanza italiana per discendenza in via amministrativa?
Vi sono due diverse modalità per presentare la domanda di cittadinanza italiana per via amministrativa:
- attraverso il Consolato italiano, nel Paese di provenienza del richiedente;
- direttamente in Italia, con istanza da presentare al Sindaco del Comune di residenza.
Nella prima ipotesi vi è lo svantaggio dei tempi da attendere. Per esempio, in Brasile (in cui vi sono milioni di discendenti di avi italiani interessati ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana) i consolati, in media, hanno bisogno di 10 anni per portare a termine il procedimento. Ciò a causa di scarse risorse da impiegare e di mancanza di organico sufficiente nell’Amministrazione italiana.
Per questi motivi, la soluzione più vantaggiosa può essere la seconda ipotesi, ossia richiedere la cittadinanza direttamente in Italia. Il richiedente, in tal caso, se non è già radicato in Italia, deve provvedere, innanzitutto, a fissare la residenza nel Comune italiano dove sceglie di presentare la domanda di cittadinanza.
La scelta riguardo il Comune è pienamente libera e non vi è bisogno di rivolgersi al Comune di nascita dell’avo italiano.
In quanto tempo si può ottenere la cittadinanza per via amministrativa in Italia?
Non si può prevedere la durata esatta del procedimento, dato che vi sono diverse variabili, tra cui, il tempo che occorre al Consolato italiano di riferimento nel rilascio, al Comune, dell’attestato di mancata rinuncia alla cittadinanza degli ascendenti del richiedente.
Attualmente, di media occorre circa un anno e mezzo, ma possono incidere diversi eventi processuali non preventivabili a priori.
Possiamo solo indicare con certezza il parametro riferito alla durata massima del procedimento: infatti, per legge, il procedimento deve concludersi entro il termine di 180 giorni.
Quali sono le fasi del procedimento amministrativo per ottenere la cittadinanza italiana per discendenza?
Passiamo in rassegna gli oneri e le fasi che caratterizzano questo procedimento.
- dichiarazione di presenza: primo adempimento di legge necessario per rispettare le norme in materia di immigrazione in Italia (articolo 1 della Legge 68 del 2007). È un onere che serve ad attribuire data certa all’ingresso dello straniero, in caso di soggiorno di breve durata (massimo 3 mesi), per il quale non bisogna richiedere il permesso di soggiorno. La dichiarazione di presenza va resa presso l’Autorità di frontiera (se lo straniero non proviene dall’Area Schengen) oppure al Questore, entro otto giorni dall’ingresso (se lo straniero proviene dall’Area Schengen). Precisiamo che oggi dello spazio Schengen fanno parte 27 Paesi (23 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, i restanti sono tutti i membri dell’Associazione europea di libero scambio – ossia Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera- e, in più, la Croazia)
- richiesta di un codice fiscale : da presentare all’Agenzia delle Entrate italiana competente per territorio
- presentazione della domanda di residenza: è fondamentale fissare la residenza presso il Comune che il richiedente ha scelto. Secondo la circolare numero 32 del 2007 del Ministero dell’Interno italiano, la dichiarazione di presenza prima descritta basta per l’iscrizione anagrafica (quindi, in deroga alle norme in materia di immigrazione, non bisogna possedere un permesso di soggiorno per avviare questo procedimento). Chiaramente, come presupposto, vi deve essere la disponibilità di un alloggio. Si può quindi stipulare un contratto di locazione con il proprietario di un immobile o un contratto di comodato d’uso; altrimenti, il proprietario stesso può rilasciare una dichiarazione di ospitalità.
Una volta depositata l’istanza all’Ufficio dell’anagrafe, i vigili italiani incaricati dal Comune, come abbiamo detto in precedenza, verificheranno l’effettiva residenza e dimora. Le tempistiche possono variare in base alla grandezza del Comune scelto (per i più grandi, fino ad 1 mese). Nell’attesa della visita, è importante che il richiedente resti a casa disponibile, per evitare altre lungaggini.
Presentazione della domanda di cittadinanza dopo l’iscrizione all’anagrafe.
L’interessato deve consegnare al Comune tutta la documentazione attestante la discendenza (con anche il certificato negativo di naturalizzazione dell’avo italiano) opportunamente tradotta e legalizzata dall’autorità consolare, oppure “apostillata” (se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961).
Il Comune provvede alla verifica della documentazione, accerta la regolare trasmissione della cittadinanza dall’avo italiano fino al richiedente e richiede all’autorità consolare italiana competente (in base della residenza o domicilio dei vari antenati) il certificato di mancata rinuncia alla cittadinanza da parte degli antenati stessi. Questo è il passaggio che più può incidere sulla durata complessiva del procedimento. Nel caso si oltrepassino i 3 mesi, bisognerà richiedere il permesso di soggiorno per “attesa cittadinanza”.
Ultimi adempimenti:
finita l’istruttoria e accertati tutti i presupposti di legge, vi è il riconoscimento della cittadinanza italiana tramite provvedimento del Sindaco. Il richiedente (oppure la persona delegata) procede a richiedere al Comune il certificato di cittadinanza e l’atto di nascita trascritto nel registro civile italiano. Di conseguenza, potrà richiedere anche la carta d’identità e il passaporto italiano (anche se quest’ultimo può sempre essere richiesto al Consolato italiano del Paese di provenienza).
Questi documenti sono utili per la diversa procedura di iscrizione all’AIRE (anagrafe italiana dei residenti all’estero). La pratica in questo caso è gestita dal Consolato italiano del Paese di provenienza. In tal modo, il Comune che ha rilasciato la cittadinanza provvederà alla cancellazione dell’interessato dalla propria anagrafe della popolazione residente.
Perché è importante la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero?
Come abbiamo detto, al termine dell’istruttoria della domanda, l’ufficiale di stato civile o il console, emette un provvedimento chiamato “attestazione di cittadinanza”; è una dichiarazione prodromica ed endoprocedimentale che attesta la presenza di tutti i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana e serve per la trascrizione nei pubblici registri italiani dell’atto di nascita formato all’estero.
L’atto di nascita formato all’estero, infatti, potrà essere trascritto solo se prima è stato valutato dall’ufficiale di stato civile (che è responsabile dei registri), sempre che non vi sia contrarietà all’ordine pubblico (i casi di intrascrivibilità sono previsti all’articolo 18 del DPR 396/2000).
Per cui, gli effetti dichiarativi e il riconoscimento dello status civitatis (cioè della cittadinanza italiana), si concretizzano solamente nel momento in cui l’atto estero viene trascritto nei registri pubblici di stato civile; in questo modo avviene il recepimento da parte dell’ordinamento italiano (articolo 449 del codice civile). Il richiedente potrà godere dei diritti e del proprio status di cittadino italiano sostanzialmente dopo la trascrizione.
Quali sono i documenti necessari per dimostrare la discendenza dall’avo italiano?
La domanda di cittadinanza, come abbiamo detto, deve essere corredata di tutta la documentazione utile per dimostrare la discendenza dall’avo italiano. Si tratta di questi atti:
- atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero (rilasciato dal Comune italiano di nascita) oppure certificato di battesimo, nel caso in cui, all’epoca della nascita, non siano stati ancora costituiti i registri dell’anagrafe civile (puoi leggere questo articolo per saperne di più);
- atto di matrimonio dell’avo italiano;
- atto di morte dell’avo italiano (importante se quest’ultimo è stato coniugato in Italia, in quanto è l’unico atto a lui riferito attestante la presenza nel Paese straniero);
- certificato negativo di naturalizzazione, ossia un certificato rilasciato dall’autorità competente del Paese estero di emigrazione (tradotto in italiano), attestante che l’avo italiano emigrato non acquisì, ai tempi, la diversa cittadinanza estera prima della nascita dell’ascendente del richiedente. Nel certificato devono essere riportati tutti i nomi dell’avo italiano che compaiono nei certificati anagrafici dell’albero genealogico;
- atti di nascita di tutti i discendenti in linea retta dell’avo italiano (anche quello del richiedente la cittadinanza italiana);
- atti di matrimonio dei discendenti in linea retta dell’avo italiano (anche quello dei genitori del richiedente);
- atti di morte dei discendenti in linea retta dell’avo italiano.
Attenzione. Per evitare il rischio che la cittadinanza venga negata, è indispensabile che i certificati anagrafici elencati siano formalmente in regola con la normativa prevista nel D.P.R. 445/2000. Significa che devono essere tradotti, legalizzati e, contenutisticamente, devono essere privi di errori sui nomi, sulle date di nascita ecc. Insomma, devono essere del tutto corrispondenti tra di loro (per gli eventi di nascita, di matrimonio, di morte).
Cosa succede se gli atti presentati sono discordanti?
Nel caso in cui vi siano nomi, cognomi, date di nascita, età o altri dati errati, incongruenze o mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, questi vanno rettificati dall’Autorità Straniera.
Come precisato da varie note della Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’interno italiano, bisogna effettuare una ricostruzione sicura della discendenza con l’acquisizione di elementi certi sulla cittadinanza degli avi del richiedente. In questo senso, solamente le Autorità straniere, se possibile, possono sanare gli errori attraverso il compimento delle opportune verifiche.
Se vi saranno discordanze, queste saranno comunicate al richiedente; entro dieci giorni dalla notificazione, bisognerà provvedere ad effettuare le correzioni richieste, altrimenti si avrà il rifiuto della domanda.
Conclusioni
Dati i complessi adempimenti da svolgere, se hai bisogno e hai interesse a richiedere la cittadinanza italiana in questa modalità, puoi rivolgerti al nostro Studio legale. Un avvocato specializzato in materia di cittadinanza italiana per discendenza potrà seguirti in tutte le fasi del procedimento e provvedere a tutti gli adempimenti richiesti.